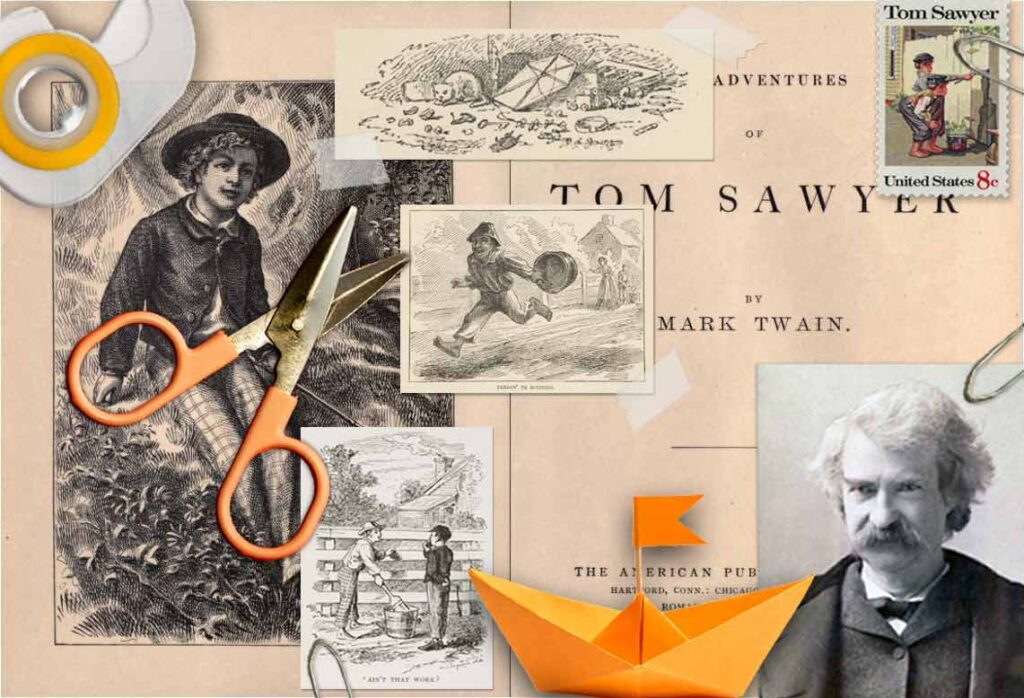Il 22 maggio del 1859, nasceva Sir Arthur Conan Doyle (Edimburgo, 22 maggio 1859 – Crowborough, 7 luglio 1930), capostipite del giallo deduttivo, padre, almeno in veste letteraria, del genio investigativo, Sherlock Holmes.
Conan Doyle – insieme a Edgar Allan Poe (Boston, 19 gennaio 1809 – Baltimora, 7 ottobre 1849) – è considerato il fondatore di ben due generi letterari: il giallo e il fantastico.
Nella sua vasta produzione, lo scrittore scozzese è passato dal romanzo d’avventura, alla fantascienza; dai temi storici al soprannaturale.
La prima opera di Doyle risale al 1879: “Il mistero di Sasassa Valley”, scritto pochi anni prima di laurearsi in Medicina e Chirurgia (1881), presso l’Università di Edimburgo. Non si trattava di un giallo, bensì di un racconto del terrore che Conan Doyle vendette al Chambers Journal.
Fu proprio mentre faceva da assistente medico a diversi dottori che iniziò ad appassionarsi alla letteratura e a scrivere le sue prime opere. Si ritiene, oltretutto che, il personaggio di Sherlock Holmes fosse ispirato a uno dei suoi professori di medicina: il brillante e freddo dottor Joseph Bell. Lo scrittore riprese anche il suo particolare metodo scientifico, oltre che le sue capacità deduttive.
Conan Doyle era indubbiamente un uomo dalle forti convinzioni, con un notevole senso dell’onore e durante la sua vita, sostenne diverse battaglie per i motivi più disparati, utilizzando la stampa per propugnare e sostenere il suo punto di vista, in modo davvero efficace e intraprendente.
Visse una gran varietà di esperienze umane: passò dalla povertà a una grande notorietà; conobbe anche molte persone importanti della sua epoca.
Esercitò come medico ed ebbe una lunga carriera come scrittore, praticò anche molti sport, come: cricket, biliardo, boxe, sci, motociclismo e calcio.
Fu mentre passava da un incarico di lavoro all’altro, ancora come medico, che iniziò a scrivere le avventure di Sherlock Holmes, più precisamente, nel periodo in cui aveva aperto uno studio medico nel Southsea (sobborgo di Portsmouth).
Le storie del singolare detective iniziarono ben presto ad avere un discreto successo. Il primo romanzo, dove compare questo singolare e arguto personaggio, risale al 1887: “Uno studio in rosso”, pubblicato sul Beeton’s Christmas Annual.
In questa prima apparizione, Doyle presenta Sherlock Holmes, delineando le principali caratteristiche del suo acuto investigatore e esponendo, al contempo, la perspicace scienza della deduzione che contraddistingue il suo metodo di indagine. Lo fa, utilizzando la voce del dottor Watson che in un certo senso è il suo alter ego.
Nel 1880, compare una seconda avventura di Sherlock Holmes, “Il segno dei quattro”, questa nuova avventura dell’infallibile detective gli decretò un enorme successo.
Nonostante la notorietà di Doyle sia dovuta proprio al personaggio di Holmes, il rapporto fra i due fu piuttosto contrastato: lo scrittore lo odiava, perché era diventato più famoso di lui.
Inoltre, Doyle avrebbe preferito esplorare generi letterari diversi, come l’avventura o il fantastico oppure dedicarsi a opere di ricerca storica, invece di soffermarsi prevalentemente sui gialli.
L’elemento fantastico penetra, però, anche in alcune storie di Sherlock Holmes, ad esempio, il romanzo “Il mastino dei Baskerville” (1902) e il racconto “Il vampiro del Sussex” (1927).
Il personaggio di Sherlock Holmes è comparso in quattro romanzi e cinquantasei racconti ed è diventato l’emblema del giallo. Inoltre, il successo di cui è stato oggetto lo ha portato a uscire dalle pagine scritte, per passare nel mondo del teatro, del cinema e della TV, e, secondo alcuni critici, è la più famosa figura di detective della storia del giallo.
Doyle ci presenta Holmes in questo modo: “il suo sguardo era acuto e penetrante; e il naso sottile aquilino conferiva alla sua espressione un’aria vigile e decisa. Il mento era prominente e squadrato, tipico dell’uomo d’azione. Le mani, invariabilmente macchiate d’inchiostro e di scoloriture provocate dagli acidi, possedevano un tocco straordinariamente delicato, come ebbi spesso occasione di notare quando lo osservavo maneggiare i fragili strumenti della sua filosofia” (La scienza della deduzione, II capitolo di “Uno studio in rosso”, Mondadori, 1976).
Non sappiamo molto del passato di Sherlock Holmes e neppure della sua vita personale. Le sue storie, poi, sono quasi tutte narrate in prima persona dal dottor John Watson, amico e biografo, che Holmes conosce nel 1881, quando cerca un coinquilino con cui condividere l’appartamento al 221B di Baker Street.
La convivenza tra l’investigatore e il dottore funziona alla perfezione e anche le indagini guadagnano da questa perfetta simbiosi, mentre il rapporto tra Doyle e il suo personaggio continua a essere tutt’altro che sereno: lo scrittore giunse a un punto da tale di insofferenza nei confronti del suo investigatore, da volersi liberare di lui in modo definitivo.
Nel racconto “L’ultima avventura”, Sherlock Holmes muore, durante un duello con il suo formidabile antagonista: Moriarty.
Purtroppo per Doyle, il suo pubblico si oppose alla prematura dipartita del personaggio e lo scrittore, a malincuore, si convinse a scrivere un nuovo romanzo con lo stesso protagonista: “Il mastino dei Baskerville”, ambientato prima della presunta morte, avvenuta nel 1891.
Successivamente, siccome il corpo dell’incredibile detective non era stato rinvenuto, Doyle lo fece risuscitare e tornare alacremente al lavoro ne “L’avventura della casa vuota”, ambientata nel 1894.
Nei tre anni mancanti, Sherlock Holmes – veniamo a sapere dallo scrittore – sarebbe stato nascosto, per occuparsi di un incarico segreto da parte del governo britannico.
La carriera investigativa di Sherlock Holmes termina con un tranquillo pensionamento: il detective si ritira dapprima nel Sussex, a studiare l’apicoltura, poi in una fattoria vicino a Eastbourne, dove si occuperà di agricoltura e filosofia, ma solo dopo aver dato man forte all’Inghilterra, come agente del governo, durante la prima guerra mondiale.
Sherlock Holmes è un personaggio complesso, pieno di sorprese. Oltre a una mente brillante, il nostro intraprendente detective non disdegna di affrontare faccia a faccia i suoi avversari, anche contrastandoli fisicamente: è un eccellente schermidore e pratica il pugilato a mani nude. Inoltre, conosce il bartitsu (sistema di lotta derivato dal jujitsu giapponese), ciò lo rende uno dei primi occidentali ad aver praticato le arti marziali orientali.
Holmes possiede anche curiose conoscenze e abitudini: è in grado di distinguere all’istante vari tipi di terreno; è edotto di ogni dettaglio, riguardante misfatti commessi nel suo secolo; è un profondo conoscitore di tabacco (ha scritto un trattato su questo argomento); non disdegna i travestimenti nei quali è piuttosto abile.
Inoltre, è anche un buon violinista, oltre che un accanito fumatore di pipa.
Per quanto riguarda le capacità sociali e relazionali, nei vari romanzi, il personaggio di Sherlock Holmes mostra di avere un buon rapporto solo con il suo amico Watson, mentre sembra emotivamente distaccato e disinteressato a tutti gli altri.
Non si interessa neppure alle donne: vuole avere la mente lucida, mentre “l’amore è un’emozione, e tutto ciò che è emozione contrasta con la fredda logica che io pongo al di sopra di tutto” (“Il segno dei Quattro”).
Per le sue investigazioni, Sherlock Holmes applica il metodo scientifico: osserva la realtà circostante, raccoglie prove e indizi e poi trae le sue mirabili deduzioni.
Un’attenta osservazione dei dettagli è sempre il primo passo, cui segue la raccolta di prove inoppugnabili, grazie alle quali è possibile formulare le giuste conclusioni.
Per quanto riguarda la scrittura di Doyle, in riferimento alle storie di Sherlock Holmes, il suo linguaggio appare serratissimo, anche quando ci sono in corso dei monologhi o delle descrizioni. In entrambi i casi la scrittura è asciutta e quasi concatenata, da tale modo di procedere, si ottiene un quadro netto e preciso.
Interessante poi, è la contrapposizione tra i casi che Holmes deve risolvere, che sono di una singolarità estrema e la semplicità della loro soluzione, ovviamente, una volta risolti.
Il personaggio di Sherlock Holmes, al di là delle sue caratteristiche psicologiche e fisiche che lo contraddistinguono, risulta particolare per il contrasto tra il modo in cui appare e quello che invece è (es. tenente Colombo). È alto, ha una figura esile, all’apparenza sembra debole, mentre in realtà, è esattamente il contrario; appare come uno sciocco, mentre è chiaramente tutt’altro.
In ogni caso, le capacità di Conan Doyle non si fermano qui: non solo lo scrittore è abile nel descrivere le situazioni e i personaggi, ma sa sfruttare brillantemente anche gli elementi atmosferici, associandoli all’andamento della storia: es. una sera tempestosa collegata a eventi drammatici e straordinari.