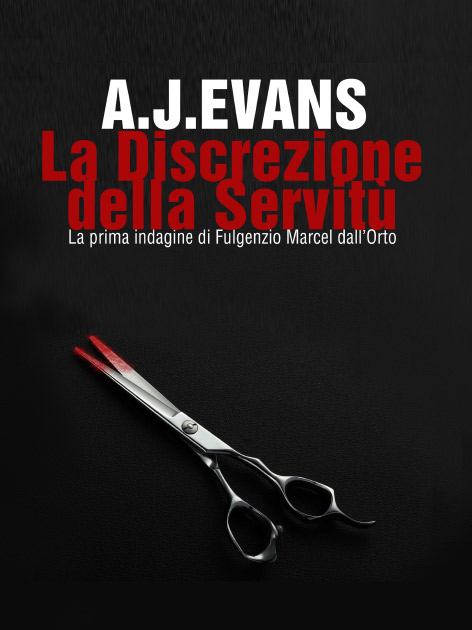Le gesta di Ulisse che tenta disperatamente e attraverso mille peripezie di tornare alla sua amata Itaca fanno ormai parte del nostro immaginario e tuttora, restiamo affascinanti dalla sua astuzia e commossi dalla sua perseveranza.
Ulisse oppure Odisseo, figlio di Anticlea e Laerte, e Re di Itaca, è un personaggio della mitologia greca, un eroe acheo, sposo di Penelope e padre di Telemaco, descritto da Omero nell’Iliade e nell’Odissea, in quest’ultimo poema compare come protagonista.
Del nome Odisseo sono state ipotizzate varie etimologie. La più comune è “iroso”, che però, non rispecchia in alcun modo il carattere del personaggio, almeno per quello che ne sappiamo leggendo il poema di Omero.
In ogni caso, il nome gli fu imposto dal nonno materno, Autolico, che secondo la sua personale interpretazione significava: “odiato dai nemici“, nemici che si sarebbe fatto per le capacità della sua mente.
Un’altra interpretazione del nome di Odisseo è “il piccolo”, quest’ultima definizione aderisce con l’affermazione fatta dall’autore riguardo alla statura di Odisseo: non altissima.
Il nome Ulisse, invece, gli fu dato dai Romani. Il nostro eroe mitologico è la “personificazione” dell’ingegno, del coraggio, della curiosità e dell’abilità manuale.
Passando in rassegna le sue origini, scopriamo che era pronipote di Ermes, mentre già sappiamo che era il marito di Penelope e il padre di Telemaco.
Se prestiamo orecchio a un’altra tradizione, dovremmo valutare l’ipotesi che il vero padre di Ulisse fosse Sisifo, che lo ebbe da Anticlea, prima che lei diventasse la moglie di Laerte.
Dal canto suo, Ulisse sosteneva di discendere per via paterna addirittura dal re degli dèi olimpi, Giove, in quanto il padre di Laerte, Arcesio, sarebbe stato figlio di Giove.
Nell’Iliade, il personaggio di Ulisse era, a detta di Omero, già piuttosto noto ai lettori e il poeta sembra avere contezza di altre favole sull’eroe dell’Odissea, oltre a quelle da lui narrate, al punto che non può togliere il personaggio dal racconto, nonostante Ulisse non abbia nell’Iliade quella parte essenziale che invece hanno personaggi come Agamennone, Menelao e Achille.
Si ipotizza che Ulisse sia una figura mitica anteriore addirittura alla colonizzazione greca oltre l’Egeo, anche se, più verosimile è l’idea che in origine si trattasse di un dio, un dio solare che scende nell’Ade come il sole che va al tramonto, ma che alla fine riesce a liberarsi, grazie all’astuzia, dai mostri del mondo sotterraneo per risorgere al mattino.
Ulisse è ritratto con grande coerenza nei due poemi di Omero. È un guerriero sagace e robusto, ardito in battaglia, oltre che scaltro e abile d’ingegno.
È un uomo che affronta con grande temerarietà e costanza pericoli e vicissitudini, ed è dotato di una notevole presenza di spirito, che lo spinge a cercare per sé e per gli altri possibili vie di salvezza.
Omero lo rappresenta come un uomo che ama profondamente la patria e la famiglia, e di entrambe avverte un’acuta nostalgia, mentre si dibatte tra mille difficoltà.
È chiaramente un uomo giusto: non mostra crudeltà nei confronti dei nemici ed è fedele verso gli amici. Inoltre, è paterno verso i suoi sudditi di Itaca e mostra amorevolezza nei confronti dei servi fedeli, mentre è inflessibile verso chi tradisce la sua fiducia.
Non tutti forse sanno che Ulisse usò la sua arguzia anche prima di allestire la trappola del cavallo di Troia, e lo fece per evitare di tenere fede al giuramento di andare a Troia.
Il nostro eroe aveva i suoi buoni motivi per essere recalcitrante alle richieste di Agamennone, accompagnato da Menelao e Palamede, che si erano recati da lui per convocarlo.
Il motivo della sua ritrosia era semplice: un oracolo gli aveva preannunciato che se fosse andato a Troia, avrebbe fatto ritorno in patria solo dopo vent’anni e in condizioni di miseria.
Ulisse allora pensò bene di mostrarsi pazzo per evitare l’infausta partenza.
Si fece trovare dai tre venuti a convocarlo con un cappello da contadino in testa, mentre arava un campo con un asino e un bue aggiogati insieme, e lanciando sale alle sue spalle.
Purtroppo per lui, Palamede lo superò in astuzia. Per accertarsi del suo vero stato mentale, tolse Telemaco dalle braccia della madre e lo mise a terra, davanti alle zampe delle bestie aggiogate all’aratro. Ulisse arretrò all’istante, tirando le redini e così, la sua follia pretestuosa fu subito smascherata e l’eroe fu costretto ad arruolarsi nella spedizione.
In copertina: Giuseppe Bottani, particolare del dipinto “Atena rivela Itaca a Ulisse” (1775) Pavia (Pinacoteca Malaspina)
(prosegue)